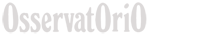CULTURA & SPETTACOLO
Vincenzo De Bellis: il percorso di un curatore d'arte atterrato in Minnesota
Vincenzo De Bellis, di casa negli Stati Uniti, ricopre l'incarico di Curator and Associate Director al Walker Art Center a Minneapolis

Questa l'intervista realizzata da Angelica Sicilia a Vincenzo De Bellis, di casa negli Stati Uniti, dove ricopre l'incarico di Curator and Associate Director al Walker Art Center, centro multidisciplinare di arte contemporanea a Minneapolis.
Da dove nasce la tua passione per l'arte?
«Nasce tra i banchi di scuola, per merito della prof.ssa Marilena Lagravinese, anche se durante gli anni del liceo classico mi piaceva più giocare a calcio che studiare. Ricordo perfettamente, però, una brillante interrogazione sull'arte etrusca che mi ha dato la carica. In realtà, avevo in testa di lavorare nel mondo del cinema. Dopo la maturità ero indeciso se iscrivermi al DAMS o alla facoltà di Beni Culturali. Poi, confrontandomi con i miei genitori, ho deciso di iscrivermi a quest'ultima, a Lecce, anche per conciliare i miei impegni calcistici, visto che ero nella seconda squadra del Castellana. Sono stato un brillante studente universitario e conservavo sempre l'ambizione di lavorare nel cinema, nel campo della produzione; non a caso mi sono laureato discutendo una tesi sulla Storia del cinema di Puglia».
Quando hai iniziato a lavorare nel campo artistico?
«Appena laureato ho iniziato a mandare curricula ovunque. La mia prima mansione è stata quella di guardiano per una sala della Fondazione Prada, a Milano. Per tre mesi mi sono occupato della sicurezza delle opere con altri ragazzi e qui ho potuto ammirare Germano Celant all'opera, mentre curava una mostra. Non avevo mai sentito parlare di questa figura professionale che mi ha da subito interessato molto: così ho iniziato a fare delle ricerche e ho capito che avrei dovuto riprendere a studiare. Vedevo il curatore come colui che fa con le opere d'arte quello che fa un regista cinematografico con gli attori: le mette in scena su un set e le fa dialogare. Volevo lavorare per un'istituzione. Pertanto, ho frequentato un Master presso l'Università “La Sapienza” di Roma, realizzato in collaborazione con il Museo Macro. Questa attività formativa mi ha permesso di iniziare uno stage al GAMeC - Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo, il posto dove ho conosciuto persone che mi hanno cambiato la vita, tra le quali mia moglie. Un museo piccolo, l'unico di arte contemporanea pubblico in quel momento in Lombardia. Qui ho fatto di tutto, dalle fotocopie al lavoro con gli artisti, e ho imparato tantissimo. Subito dopo, ho iniziato altre collaborazioni a Milano e ho fatto domanda per un ulteriore Master negli Stati Uniti. Nel 2005 ho iniziato a frequentare il “Bard College” di New York, importante scuola per curatori, seconda al mondo in ordine cronologico e molto esclusiva. Eravamo solo in nove».
Come sei arrivato alla direzione artistica di Miart, la manifestazione internazionale d'arte moderna e contemporanea di Fiera Milano?
«Quando sono tornato in Italia dagli Usa, io e altre due persone abbiamo aperto uno spazio, una micro istituzione che rispondesse al desiderio di colmare un vuoto a Milano: creare la project room di un museo, ma senza il museo. Dopo un meticoloso lavoro sul territorio, abbiamo dato vita a “Peep-Hole” (“spioncino” in inglese). Nella nostra galleria abbiamo allestito mostre a ripetizione, siamo riusciti a creare eventi di rilievo, anche grazie a operazioni di foundraising. Abbiamo raggiunto una certa notorietà, suscitando l'interesse della stampa e degli addetti ai lavori. Insomma, lo spazio si era fatto un suo nome. A un certo punto mi ha chiamato il management della Fiera, per la quale si prevedeva un rinnovamento. Inizialmente ho rifiutato la direzione ma, quando hanno continuato a cercarmi, ho dettato le mie condizioni: creare il team, portando quindici persone che a vario livello avrebbero contribuito con le loro professionalità. Al Miart ho cercato di replicare in grande l'idea dello spazio che nel frattempo andava avanti, anche grazie a donazioni e all'aiuto degli artisti che regalavano le loro opere. La cosa ha funzionato. Dopo tre anni di lavoro avevo in mente di lasciare la direzione e nel frattempo sono stato chiamato dal Walker Art Center di Minneapolis per un incarico che mi ha portato alla volta degli Stati Uniti».
Di cosa si occupa, tecnicamente, un curatore d'arte?
«Il suo lavoro dipende da tanti fattori. Se il museo ha una collezione, il curatore è il filtro tra i conservatori della collezione e il mondo esterno, è la persona che decide come allestire le opere. Se non c'è una collazione, è la persona che crea il progetto espositivo, sceglie le opere e le allestisce, si occupa di tutte le fasi della progettazione della mostra dall'inizio alla fine».
Sei uno degli italiani che ricopre un incarico di prestigio all'interno di una istituzione culturale straniera. Cosa pensi dell'acceso dibattito, sviluppatosi in Italia, a proposito dell'assegnazione della direzione museale a professionalità italiane piuttosto che estere?
«Io penso che l'idea che un direttore debba essere necessariamente nato nel paese in cui ha sede il museo sia un'assurdità. Ci sono molti italiani che occupano ruoli direttivi in istituzioni museali straniere. Sono del parere che, se si hanno le carte in tavola, è giusto affidare gli incarichi a chi merita. Per quanto riguarda lo stato dei musei italiani, quelli d'arte contemporanea statali sono solo due, il MAXXI e la Galleria d'Arte Moderna di Roma, tutti gli altri sono civici o regionali, oppure si tratta di fondazioni a partecipazione pubblica. I musei che sono totalmente legati alla politica fanno fatica perché influenzati dalla linea politica nazionale».
Cosa cambia nel sistema museale americano, invece?
«Il sistema è totalmente differente, anche nell'organizzazione. In America i musei sono tutti privati. Prendo come esempio il Walker Art Center: il nostro museo ha 28 milioni di dollari annui di costi, ma 25 vengono coperti da privati, aziende e persone fisiche, le quali se donano un dollaro al museo poi non lo pagano di tasse, preferendo dunque investire nella propria città. Questo sistema genera una reazione a catena: posti di lavoro, maggiore possibilità di progettazione, i musei sono slegati dalla politica e gestiti come fondi di investimento, le opere vengono acquistate con gli interessi generati dal denaro accumulato dal museo nelle banche. Non è il mondo ideale, ma è un mondo che funziona ed è questo il motivo per cui molti preferiscono andare in America. Le persone che fanno un lavoro in un museo straniero sentono di fare ciò per cui sono pagati e avvertono la stima. La voce di un curatore è ritenuta valida e importante nella comunità in cui opera, non posso dire che la stessa cosa accada anche in Italia».
Qual è il fermento artistico che si respira in America?
«Il fermento oggi è totalmente invertito. L'Italia ha un ruolo molto marginale, ha perso tantissimo, soprattutto perché le accademie non si sono evolute molto, sono rimaste quelle del dopoguerra. Inoltre, non viene facilitato l'arrivo di professori professionisti, contrariamente a quanto accade nel resto d'Europa. In America questo è ancora possibile. L'arte dagli anni '70 e '80 si è evoluta e adesso gli artisti sono quasi tutti americani o preferiscono vivere e operare nel territorio americano. In Italia e in Europa, certo, non mancano personalità di talento, ma non ci sono molte figure di spicco tra le nuovissime generazioni».
di Redazione
30/09/2018 alle 11:06:22
Leggi anche:
Cultura & Spettacolo
Torna a Fasano il festival “I nostri migliori anni! - 3^ Edizione” con Mara Venier
_0.jpg)
Taglio su misura + piega gloss a soli € 20
Eligio Parrucchieri ti invita a conoscere i suoi prodotti.

Stazione di servizio Q8 Cacucci
Carburanti e servizi
Efficienza e puntualità nei servizi e prodotti offerti alla clientela